Il senso di Marconi per gli affari
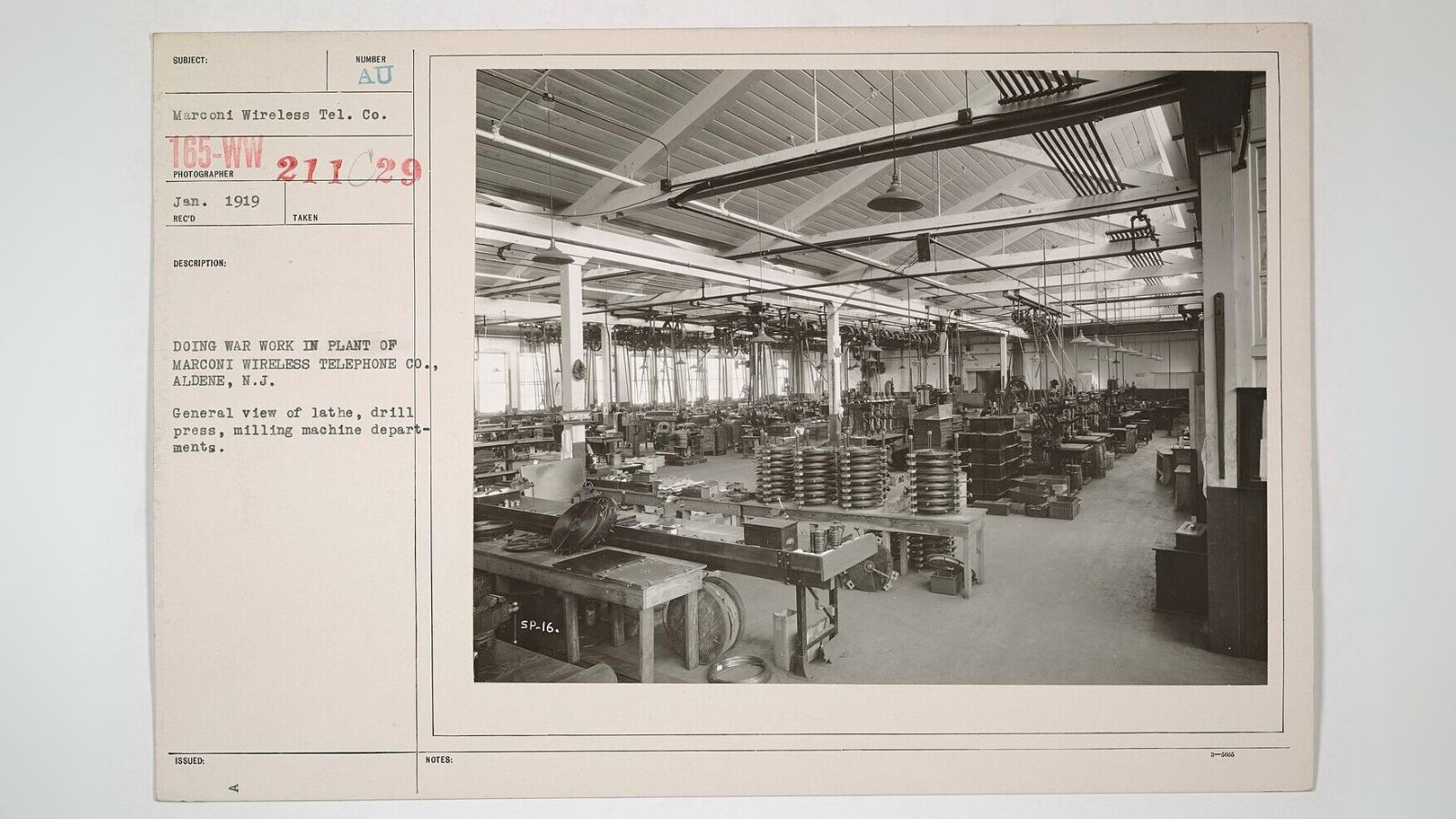
Il grande scienziato italiano deve il suo successo non solo alle scoperte in campo scientifico, ma anche a un'indiscutibile attitudine commerciale. Del resto, era figlio di due imprenditori che, evidentemente, gli hanno insegnato a brevettare e a tradurre in guadagni le sue intuizioni, come ricorda Alberto Guasco dell’Istituto di storia dell’Europa mediterranea del Cnr
Per Guglielmo Marconi le ottime doti organizzative e imprenditoriali sono stati i famosi fattori critici del suo successo, come sottolinea Alberto Guasco, ricercatore dell'Istituto di storia dell'Europa mediterranea (Isem) del Cnr: “La relazione che intercorre tra le sue invenzioni e il suo spirito imprenditoriale è strettissima. In un certo senso, la spinta a commercializzare è una diretta conseguenza delle sue invenzioni. Marconi non ha mai concepito l'una cosa senza l'altra. Non è ovviamente l'unico tra i geniali sperimentatori che abitano il confine tecnologico di fine Ottocento e inizi Novecento, ma lui fa quel passo in più a cui gli altri non avevano pensato. In tal senso è un apripista”.
La sua istruzione primaria avviene tra le mura domestiche e la sua formazione è piuttosto discontinua, frutto di una spontanea applicazione e di una forte inclinazione verso le materie scientifiche. Fosse nato ai giorni nostri, diremmo che Guglielmo Marconi ha respirato cultura d'impresa fin dall'infanzia. Il padre, Giuseppe, era un ricco proprietario terriero, mentre sua madre Anne era figlia di un distillatore di whiskey. L'inventore e fisico italiano fonda una delle sue fortune commerciali su un contratto stipulato nel 1901 con gli assicuratori della Lloyd's, che per alcuni anni gli garantisce il monopolio dei suoi apparecchi nelle strumentazioni delle navi. Appena ventiduenne, infatti, ricerca e trova a Londra un'adeguata assistenza legale che gli permette di sfruttare commercialmente la sua scoperta, a cominciare dal direttore tecnico del British Post Office, ma soprattutto entrando in contatto con il mondo della finanza. I capitali ottenuti gli consentono di perfezionare la sua invenzione e metterla a disposizione del progresso scientifico. In questo compie un ulteriore passo in avanti rispetto a studiosi come Heinrich Hertz e Thomas Edison, che avevano già compiuto esperimenti sulla telegrafia senza fili. Una prima dimostrazione di questa innovativa comunicazione era avvenuta nel 1893 da parte del serbo-statunitense Nicola Tesla, che però al posto dei segnali Morse usava le onde elettromagnetiche continue.
Nel 1897 fonda la Marconi Company che, negli anni che anticipano la Prima guerra mondiale, vende al governo britannico un notevole numero di apparecchi per la radiotelegrafia contribuendo a sopperire al gap nelle strutture tecnologiche che si stava aprendo con la Germania guglielmina. Le vicende della Marconi Company sono soggette a fortune alterne, a contenziosi con la Germania, all'ostilità statunitense che vede nella compagnia uno strumento del governo inglese, a sua volta non sempre corretto verso l'impresa marconiana.

Esistono almeno tre chiavi di lettura che aiutano a interpretare la sua propensione agli affari. “Il primo elemento è l'influenza paterna. Il padre di Marconi, da quanto ne sappiamo, è stato un uomo attentissimo ai bilanci e capace di far quadrare sempre i propri conti”, spiega Guasco. “La distanza di età che lo divide dal figlio, che nasce quando lui ha 50 anni, non gli impedisce di trasmettergli il suo background. Un grande ascendente su di lui lo esercita anche la madre, che proviene da un'altra famiglia di imprenditori i cui capitali saranno fondamentali per il successo che Marconi avrà in Gran Bretagna. E poi c'è Marconi stesso, che fin da giovane ha introiettato questa lezione. Esiste un carteggio del 1883 con suo cugino, in cui parla dei suoi esperimenti e del desiderio di brevettarli. Quindi c'era già nel giovane Marconi la capacità di capire che le applicazioni scientifiche hanno un potenziale imprenditoriale e che quel potenziale va difeso”.
Guglielmo ama sperimentare e grazie alla sua ottima conoscenza dell'inglese legge i migliori trattati scientifici internazionali ed entra in contatto con i giganti della scienza di allora, tra cui Augusto Righi, impegnato a confermare in via sperimentale la teoria elettromagnetica della luce di Maxwell. È così che lo scienziato matura l’idea di un “telegrafo senza fili”, uno strumento in grado di utilizzare le onde elettromagnetiche per inviare segnali a distanza. Ma se non avesse avuto l'arguzia di “mettere al sicuro” le sue scoperte, anche Marconi sarebbe finito nel calderone dei dimenticati e le sue opere sarebbero state commercializzate da altri, magari meno brillanti ma più intraprendenti studiosi? “Questo è molto difficile da dire. La storia non si fa con i se, ma d'altro canto possiamo anche fare la storia con i se e fermarci almeno al livello di ipotesi. Potremmo ipotizzare che Marconi sarebbe stato un Reginald Fessenden o un Aleksandr Popov, al limite anche un Tesla, oppure sarebbe stato inserito nella categoria degli inventori geniali, che però non hanno avuto un fiuto commerciale nel coniugare tecnica, scienza e mercato, i tre grandi pilastri su cui si Marconi ha fondato la sua fortuna”, conclude l'esperto.
Fonte: Alberto Guasco, Istituto di storia dell'Europa mediterranea, alberto.guasco@cnr.it